Associazione ARPEA Onlus
- Dettagli
- Visite: 11055
-
L’ombrello delle identità di genere
- (immagine da Sinapsi)
Identità di genere
L’identità di genere è il profondo senso soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di “maschio/femmina”. Può essere binaria o non binaria. Il genere binario, è la classificazione di sesso e genere in due forme mutualmente esclusive maschio-femmina. Il genere non binario definisce quelle identità di genere che non sono strettamente né maschili né femminili.
Chi si riconosce nel sesso assegnato alla nascita e si conforma al relativo genere è detto cisgender, chi non si riconosce nel sesso o nel genere assegnato alla nascita si definisce transgender.
Tutte le società hanno una serie di categorie di genere che possono servire come base per la formazione dell’identità di genere delle persone in relazione agli altri membri della società.
Ma vediamo più nel dettaglio alcune delle innumerevoli identità di genere esistenti nella comunità LGBTQ+.
Transgender
Il termine transgender è un termine ombrello che indica tutte le persone con un’identità di genere non corrispondente al genere e/o al sesso assegnato loro alla nascita. Si definiscono transgender, quindi, le persone che si identificano in modo transitorio o persistente con un genere diverso da quello assegnato.
Le persone transgender possono provare disforia di genere (malessere dato dalla discrepanza tra le caratteristiche sessuali e l'identità di genere) e decidere di operare una transizione verso il sesso cui sentono di appartenere attraverso trattamenti medici come la terapia ormonale o la riassegnazione del sesso.
Le persone trans subiscono discriminazioni di varia natura, dalle discriminazioni sul posto di lavoro, al misgendering, ovvero l’utilizzo volontario del genere sbagliato per riferirsi alla persona (es: riferirsi a una donna trans al maschile), all’utilizzo del deadname (il nome che la persona aveva prima di intraprendere la transizione o che non decide più di usare in favore di un altro che si allinea maggiormente con la sua identità di genere).
Inoltre, anche utilizzare la parola “trans” come sostantivo e non come aggettivo è discriminatorio, in quanto l’essere transgender è una semplice caratteristica della persona e non ne descrive l’esistenza. Il modo corretto per rivolgersi a queste persone è infatti “uomo/donna transgender”.
Non-Binary
Il termine non-binary è un termine ombrello che racchiude tutte quelle identità che non riconoscono la costruzione binaria del genere e che operano un esercizio critico del genere, non ritendendolo qualcosa di dato una volta per tutte.
Le persone non binarie possono soffrire di disforia di genere, anche se spesso provano più disforia sociale, ovvero avversione per il proprio nome assegnato alla nascita, per linguaggio e pronomi che identificano la persona secondo il suo sesso e non secondo la sua identità di genere, o per i ruoli di genere imposti. Inoltre, spesso ma non sempre, le persone non binarie non rifiutano aspetti attribuiti al genere maschile o femminile, utilizzando o rifiutando aspetti dei costrutti di genere che sentono più vicini al loro modo di essere.
L’identità non binaria può essere vissuta e declinata in molti modi diversi. Questo ha portato a una gamma di definizioni molto vasta che può dare un’idea del rapporto che queste identità hanno con i due generi “canonici”. Vediamone alcune nello specifico.
Multigender
Il termine multigender è utilizzato per chiunque abbia più di una identità di genere. Le persone multigender possono avere due o più identità di genere nello stesso momento, oppure possono cambiare identità di genere nel tempo. Le identità che sperimentano possono essere femminili, maschili, non binarie o senza genere.
Il termine può essere usato come identità di genere a sé stante o come termine ombrello.
Le identità multigender includono anche le persone pangender (tutti i generi), che sperimentano una molteplicità di identità di genere, simultaneamente o in maniera fluida nel tempo. Le persone pangender riconoscono l’esistenza di così tanti generi da essere impossibile elencarli tutti. Essere pangender significa quindi “avere tutte le identità di genere che è possibile avere”, ovvero identificarsi in tutti i generi noti e in quelli ancora sconosciuti.
Genderfluid
Le persone genderfluid hanno un’identità di genere che oscilla lungo lo spettro di genere variando nel tempo. Possono in qualsiasi momento identificarsi come maschio, femmina, agender o qualsiasi altra identità non binaria.
Agender
Il termine agender, letteralmente “senza genere” può essere visto come una dichiarazione di non avere un’identità di genere o come un’identità non binaria. Le persone che si identificano come agender possono descriversi come:
- senza genere;
- di genere neutro, nel senso di non essere né uomo né donna pur avendo ancora un genere;
- persone che non si allineano con nessun genere;
- persone che decidono di non etichettare il proprio genere;
Genderqueer
Il termine genderqueer è un termine generico usato per descrivere qualsiasi identità di genere diversa dall’identità di genere maschile e femminile. È un termine ombrello che include chiunque non sia cisgender o eterosessuale. Si identifica genderqueer chiunque ritenga di avere un’identità di genere non conforme con il sesso attribuito alla nascita, né con la dicotomia binaria maschio/femmina.
Le persone genderqueer possono quindi appartenere a un terzo genere, a entrambi o a nessuno, e possono scegliere un percorso medicalizzato per avvicinarsi di più alla rappresentazione fisica che sentono propria.
Genderqueer può essere utilizzato anche per riferirsi a qualsiasi persona che trasgredisce le distinzioni tradizionali di genere, indipendentemente dalla loro identità di genere auto-definita.
Come abbiamo visto, la concezione di genere si è molto ampliata nel corso del tempo, andando a includere identità che non rientrano nel dualismo uomo-donna. Per comprendere la natura di costruzione sociale del genere è interessante guardare ad altre culture non occidentali, che presentano una struttura sociale che riconosce più di due generi. Ad esempio, nella cultura dei nativi americani, è riconosciuto un terzo genere, “Two-Spirit”, proprio di persone che hanno una doppia spiritualità, maschile e femminile.
Il genere è categorizzato secondo stereotipi sociali, spesso limitanti e opprimenti anche per le persone cisgender. Applicare una visione fluida e non binaria del genere non è solo un modo di autodeterminarsi, ma è costituisce anche una forma di dissenso verso un sistema che può impedire la libera espressione di sé.
Ciò che la comunità LGBTQ+ sta cercando di portare alla luce, oltre alla necessità di acquisire maggiore visibilità, è la volontà di liberarsi da stereotipi limitanti, di vivere la propria vita nel rispetto della propria e altrui individualità, senza giudizi e pregiudizi.
Rispettare ciò che si è. Essere ciò che si è. Senza costrizioni, ascoltando la parte più intima di ognuno di noi e vivendo appieno la vita, liberi da gabbie che ci impediscono di volare alto, verso l’arcobaleno.
Di Erica Manta
- Dettagli
- Visite: 6148
 nella foto Ezra Miller, attore queer, Met Gala 2019 (fonte Pinterest)
nella foto Ezra Miller, attore queer, Met Gala 2019 (fonte Pinterest)
L’alfabeto arcobaleno del Pride
Nel corso degli anni, sono stati coniati nuovi termini e si è ridefinito il significato di altri per dare voce a tutte le identità presenti nella comunità LGBTQ+.
Questi termini hanno consentito alle persone della comunità di definirsi e di affermare la propria esistenza, in un processo di identificazione che passa anche attraverso il linguaggio.
Si tratta di parole nuove, a volte poco conosciute, il cui significato può essere confuso o ignorato.
A tal proposito, abbiamo costruito un alfabeto arcobaleno per chiarire il significato e la storia di alcuni termini e parlare in modo consapevole del mondo LGBTQ+
Oggi ci soffermeremo sul significato di Queer.
Queer è un termine inglese che si potrebbe tradurre con “bizzarro”, “strano”, “eccentrico”, ma anche “storto, obliquo”. Veniva usato per designare le persone omosessuali in un’accezione negativa e dispregiativa, equivalente dell’italiano “che*ca” o “fr*cio”.
Dopo i primi moti di liberazione degli omosessuali, quando all’interno del movimento iniziano a essere incluse anche le istanze delle donne lesbiche, delle persone bisessuali e transgender, iniziano a sollevarsi all’interno della comunità alcune critiche che vedono i termini “gay”, “lesbica” e “bisessuale” come frutti di una prospettiva eteronormativa e binaria, che rischia di racchiudere la persona in uno stereotipo limitante.
È in questo contesto che la comunità si riappropria del termine Queer, svuotandolo della sua valenza negativa e rendendolo un termine attraverso il quale autodeterminarsi come una persona che non si riconosce nel binarismo di genere e non vuole essere incasellata in una definizione strettamente legata alle proprie preferenze sessuali.
In altre parole, queer è un termine ombrello che indica tutte le sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e viene utilizzato da tutti coloro che non vogliono identificarsi in un’etichetta, non affermandosi né come etero/cisgender, né come transgender, omosessuali, lesbiche o di altri orientamenti e identità di genere.
Queer identifica anche un campo di studi sulle questioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e sulle intersezioni che queste hanno con altre posizioni identitarie come la classe sociale o la disabilità.
Questi studi fanno riferimento a una “Teoria Queer”, nata ad opera della studiosa italiana Teresa De Lauretis, che si focalizza sulla messa in discussione dell’omonormatività, che definisce l’aspetto normativo ed escludente della cultura omosessuale creando un modello di riferimento a sua volta escludente di quelle soggettività che per diverse ragioni non si attengono a tale modello.
La “Queer theory” è dunque un campo di studi sulle sessualità lesbiche, gay, ma anche di impegno teorico-pratico in cui le esperienze delle persone non eterocis possano incontrarsi e intersecarsi tra loro per divenire terreno di discussione e rivendicazione comune.
La Teoria Queer cerca quindi di comprendere tutte le identità sessuali e di genere, sforzandosi di avere uno sguardo più ampio di quello etero-normativo che finisce per definire, per opposizione, anche chi non si riconosce nel binarismo di genere.
In sintesi, chi si definisce queer intende determinare una rottura con la norma eterosessuale e con la visione stereotipata delle identità non cis-etero, sottolineando la fluidità dell’identità sessuale e la complessità dei diversi aspetti che la compongono.
La bellezza di questo termine sta nella sua liquidità. La dimensione individuale è esaltata al massimo, e sono il corpo, il genere e il desiderio di ogni individuo a definire i margini della queerness: un’azione rivoluzionaria che rompe gli schemi normativi per una persona può essere estremamente ordinaria per un’altra, ma questo non inficia l’essere queer di nessuno.
Questo assunto deriva dal fatto che il concetto di norma sia molto variabile, e che dunque qualsiasi atto di rivoluzione e sovvertimento delle regole di genere sia valido. D’altronde, la teoria queer identifica il genere come un costrutto sociale, e dunque non come un “essere”, ma come un “fare” le “donne”, gli “uomini”, o le persone “queer”.
Si tratta allora di categorie sovraordinate di cui è possibile esprimere alcuni tratti e contaminarne altri, lanciando ogni giorno una sfida alla norma binaria ed etero-normata.
Pensare al genere come qualcosa di binario significa identificare il genere con le sole caratteristiche biologiche dell’individuo e definire lo spazio e il ruolo delle persone in base al dualismo “maschio” e “femmina” e a tutti i corollari e costrutti culturali che questi due generi portano con sè.
Al contrario, pensare al genere come qualcosa di non binario, significa rifiutare l’idea che esistano solo due generi, non ritenere il genere qualcosa di dato una volta per tutte, ma riconoscergli una certa fluidità che consente alle persone di scegliere come definirsi.
Definirsi queer vuol dire collocarsi al di fuori del mondo binario, aprendosi a nuove possibilità ed esprimendo la propria identità in modo libero e secondo il proprio sentire, mescolando elementi tipici delle identità definite ed esprimendo sé stessi aldilà degli stereotipi. Significa dissentire.
Di Erica Manta
- Dettagli
- Visite: 6860
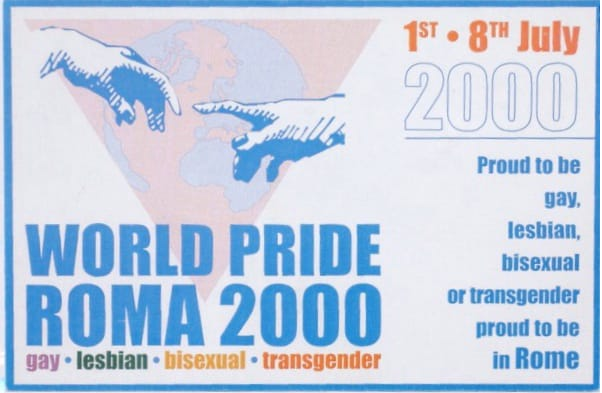
Logo del World Pride 2000 (immagine da roma.repubblica.it)
Ogni anno a giugno le strade, le piazze e i palazzi si riempiono di bandiere arcobaleno. Giugno è infatti il mese del Pride, conosciuto a livello internazionale come Pride Month, durante il quale si celebra l’orgoglio della comunità LGBTQ+ (acronimo di “lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer”, termine utilizzato per riferirsi a tutte le persone che preferiscono non identificarsi in una specifica “etichetta” relativamente all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere. Il segno “+” rappresenta infine tutte le altre identità che non trovano posto nell’acronimo).
Questa è la prima parte di una rubrica che vi accompagnerà per tutto il mese di giugno, per approfondire o chiarire terminologie, temi e istanze della comunità LGBTQ+.
Ma quindi, perché proprio giugno è il mese del Pride?
Il mese del pride è frutto della celebrazione dell’anniversario dei fatti di Stonewall del 1969, evento cardine del movimento di liberazione degli omosessuali: proviamo a raccontare la storia di questi fatti, d’altra parte le storie hanno un grande potere, ad esempio esse possono insegnare, e talvolta anche curare.
Negli anni Sessanta, essere omosessuale era illegale in 49 stati americani, motivo per cui iniziarono a nascere le prime associazioni di protesta e i primi gay bar, dove le persone della comunità LGBT potevano trovare rifugio ed essere sé stesse senza sentirsi costantemente in pericolo. I gay bar erano gli unici posti in cui le persone della comunità potevano esprimersi liberamente e per questo erano spesso presi di mira dall’intolleranza conservatrice, la polizia stessa periodicamente faceva irruzione nei locali per incutere timore tra gli avventori e minacciarne la tranquillità e la sicurezza.
Il 28 giugno 1969, ci fu un’irruzione nello Stonewall Inn, uno dei locali gay più famosi e frequentati di New York, e la polizia arrestò 13 persone con l’accusa di indecenza e di vendita illegale di alcolici. Ma quella notte, gli atteggiamenti violenti delle forze dell’odine, la distruzione di ambienti considerati protetti dalla comunità, il profondo senso di ingiustizia infiammarono gli animi degli avventori che, stanchi di essere sottoposti a tali forme di sopruso, si ribellarono, dando inizio a cinque giornate di protesta al grido di “Gay Power”, che sono passate alla storia come i Moti di Stonewall.
Le conseguenze di questi eventi sono state enormi: in America e nel mondo nacquero diversi movimenti in difesa dei diritti degli omosessuali, l’attivismo diventò una forma di protesta agguerrita, le persone della comunità iniziarono a far sentire la propria voce, a organizzarsi in collettivi e a lottare per le proprie rivendicazioni.
Un anno dopo, il 28 giugno 1970, a New York si tenne il primo Gay Pride della storia: una marcia a Central Park per commemorare i fatti dell’anno precedente. Nello stesso anno, anche in altre città americane si tennero manifestazioni in ricordo dei Moti di Stonewall, trasformando la commemorazione in un evento fisso che ricorre ogni anno.
Nei primi anni 70, anche in Italia iniziarono a prendere vita le prime associazioni e comitati per i diritti e ad essere organizzate le prime proteste, come quella di Sanremo del 1972, organizzata per interrompere un convegno sulla sessualità a Sanremo, il quale proponeva temi quali le terapie di conversione per omosessuali, ma bisogna aspettare il 1994 per il primo Pride ufficiale, organizzato a Roma dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che è tutt’ora il circolo organizzatore del Roma Pride. La manifestazione fu una rivoluzione per l’Italia: più di diecimila persone manifestarono contro l’odio e la violenza per rivendicare i propri diritti e la propria esistenza. Il successo di quell’evento fu replicato a Bologna e Verona l’anno dopo, estendendosi, anno dopo anno, a molte città italiane, fino ad arrivare all’organizzazione del World Pride di Roma del 2000, un evento senza precedenti a cui parteciparono quasi cinquecentomila persone arrivate da ogni parte del mondo.
Dal 2014, le associazioni LGBTQ+ hanno deciso di riunire sotto un unico movimento le varie iniziative italiane sotto l’Onda Pride, un’onda arcobaleno che ogni anno travolge la Penisola con forza e voglia di lottare.
Conoscere la storia dei Moti di Stonewall e di tutto ciò che essi hanno comportato, consente di capire qual è il ruolo dei Pride oggi. Non si tratta solo di prendere parte a una festa, ma anche di un modo per ricordare chi ha perso la vita, chi è stato umiliato ed emarginato, chi ancora oggi ha paura di uscire di casa, chi subisce discriminazioni a lavoro, per strada o a scuola. Partecipare oggi al Pride vuol dire affermare la propria esistenza, rendersi visibile e rivendicare il diritto a essere chi si è. I Pride sono commemorazione, celebrazione, ricordo, desiderio di libertà e lotta. E conoscerne le radici è il miglior modo per iniziare a lottare, per comprenderne il senso e la necessità.
Dal 1994, molto è stato fatto, e alcuni traguardi sono stati raggiunti, seppur con fatica. Tuttavia, molto è ancora da fare, ed è per quello che ancora non si è raggiunto che si continua a manifestare. Per una visibilità che la comunità ha deciso di prendersi, per il diritto all’autodeterminazione, per lasciare alle persone di domani, un mondo in cui la diversità non rappresenti un deficit bensì una risorsa, una possibilità di arricchimento. Si marcia per conquistare un luogo di riconoscimento in cui non sia pensabile essere picchiati o umiliati, o addirittura uccisi, per essere semplicemente quel che si è. Si marcia anche per affermare il proprio diritto all’esistenza, un diritto che passa anche attraverso le parole che ti definiscono, che dicono chi sei, che ti plasmano nel mondo.
Parole che spesso non si conoscono, che sembrano estranee, ma il cui unico scopo è dire: “Io esisto. Io sono questə.” Parole che spesso possono essere disorientanti. Parole che abbiamo raccolto qui, nella speranza di aggiungere un tassello alla comprensione delle diverse sfumature delle esistenze umane. Dei diversi colori che compongono l’arcobaleno.
Di Erica Manta
- Dettagli
- Visite: 2138

Mahsa Amini, volto del dissenso in Iran
La violenza contro le donne, nelle sue molteplici declinazioni, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo e, nonostante le differenze culturali tra i vari paesi della comunità internazionale, questa appare quasi come una costante, sebbene possano esserci forme di violenza esclusive o più diffuse in alcuni contesti piuttosto che in altri.
In alcuni casi, la violenza contro le donne viene sì materialmente perpetrata da uomini, ma il vero carnefice sono le istituzioni politiche e religiose o una combinazione di entrambe, che introducono, o perpetuano, negli ordinamenti interni dei propri paesi, figure di reato, e relative pene, assolutamente discriminanti e lesive dell’integrità e della dignità di donne e ragazze.
Il caso che forse quest’anno ha fatto più scalpore è quello, tristemente noto, della morte della giovane curda iraniana Mahsa Amini, assassinata dalla polizia morale iraniana per aver indossato in maniera non conforme alla legge l’hijab, obbligatorio in Iran. La ragazza, fermata dalla polizia mentre passeggiava con i genitori per le strade di Teheran, è stata portata via con la forza dalle autorità, caricata su un’auto e condotta nel centro di detenzione di Vozara, tra violenze e percosse di una tale brutalità da farla andare in coma. Mahsa morirà tre giorni dopo, nell’ospedale di Kasra (1).
Le autorità iraniane hanno annunciato l’avvio delle indagini negando tuttavia qualsiasi illecito da parte della polizia, alimentando così l’indignazione e la rabbia della società civile, scesa in piazza a rivendicare maggiori diritti e libertà e a manifestare il proprio dissenso in merito alle discriminazioni e ai metodi brutali di un regime sempre più totalitario e misogino (2). Anche in questo caso, le autorità iraniane hanno risposto attraverso una selvaggia repressione, provocando la morte di più di cento manifestanti, molti dei quali minorenni, tra cui le sedicenni Nika Shakarami e Sarina Esmailzadeh, entrambe assassinate per aver preso parte ai cortei di protesta a seguito della morte di Mahsa.
Sebbene la violenza contro le donne venga spesso narrata e affrontata come una questione di natura meramente privata, le sue dimensioni e la sua portata necessitano di inquadrare il problema da un punto di vista culturale, sociale e addirittura politico. Tale fenomeno infatti non solo è largamente diffuso in tutto il mondo, ma viene spesso tollerato e addirittura legittimato da molti governi nazionali di diversi paesi in cui la donna è relegata ai margini della società e non è portatrice dei medesimi diritti degli uomini. Culture e strutture sociali patriarcali, legislazioni e pratiche discriminanti nonché l’ingerenza della politica e della Chiesa nella sfera privata, coi relativi tentativi di controllo del corpo della donna, contribuiscono a creare una società in cui donne e ragazze sono costantemente sminuite, mortificate ed esposte ad atteggiamenti discriminatori e pregiudizievoli tanto per la loro incolumità psico-fisica quanto per il rispetto dei loro diritti.
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne serve dunque, da una parte, a ricordare le vittime di ogni tipo di violenza basata sul genere e, dall’altra, a focalizzare l’attenzione di vari attori, nazionali e internazionali, su un problema sempre più diffuso e drammatico, in un’ottica di cooperazione che renda le donne protagoniste del proprio empowerment.
di Roberta Carbone
(1) https://www.amnesty.it/appelli/iran-proteggere-il-diritto-di-protesta/
(2) https://www.affarinternazionali.it/mahsa-amini-e-il-regime-svelato-tornano-le-proteste-in-iran/
- Dettagli
- Visite: 26374
 C’era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus: Coronello. Era famoso per il suo caratterino: ribelle, dispettoso, disubbidiente. Lo chiamavano, scherzosamente, “Coronello il virus birbantello”!
C’era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus: Coronello. Era famoso per il suo caratterino: ribelle, dispettoso, disubbidiente. Lo chiamavano, scherzosamente, “Coronello il virus birbantello”!
È arrivato anche da noi questo virus diffondendosi a macchia d’olio. È invisibile, microcoscopico un nemico difficile da intercettare e combattere. Forse proprio per la sua invisibilità è difficile accettare delle restrizioni così forti, che spingono ad abbandonare tutte le attività e a limitare in maniera drastica tutti i legami sociali. Sappiamo poco sul virus, non abbiamo ancora un vaccino, non conosciamo il suo comportamento, né il numero di persone che potrà contagiare. Tutto questo “non sapere” ci fa sentire persi, smarriti, confusi, preoccupati.
I bambini necessitano di informazioni CHIARE E VERE, filtrate in base all’età, in modo che possano essere comprese.
È importante non esporre i bambini o sovraesporli a immagini e notizie non adatte al loro livello di comprensione. Il messaggio che bisogna trasmettere è che i grandi stanno facendo di tutto per far passare la bufera. Questi giorni passati a casa, in cui non possono vedere i compagni o giocare a pallone, in cui le loro scuole sono state chiuse, servono a questo. Per vivere meglio, evitare che altra gente si ammali e tornare alla vita di tutti i giorni il più presto possibile.
È utile dire ai bambini di lavarsi le mani e spiegare perché è importante farlo. Ma sarebbe sbagliato dire “stai attento sennò questo ti si attacca addosso e se ti tocchi gli occhi sono guai”. Qualcosa di invisibile che si incunea. Terrificante. Diamogli delle regole di igiene senza però aumentare l'intensità della paura.
È fondamentale rafforzare la fiducia e la sicurezza nei bambini. Devono continuare a fare le loro attività come giocare, parlare di cose divertenti fare i compiti e imparare cose nuove.
Sicuramente l’obbligo di restare a casa ci permetterà di avere un tempo familiare condiviso, che per il bambino è uno spazio prezioso. Si possono condividere molte attività, dalla pittura alla cucina, alla costruzione, ai giochi di carte, alla invenzione di favole.
La tecnologia permetterà ai piccoli di poter vedere i compagni di classe in videochiamata e sentirsi meno soli.
Stare con mamma e papà e altre persone di fiducia senza che vedano solo volti spaventati e allarmati. Ricordiamoci che i bambini sono piccoli ma osservano e comprendono tutto.
Un bambino per sentirsi sicuro non deve vedere un adulto che finge, è legittimo essere preoccupati, così come è importante trovare insieme delle soluzioni. I bambini sanno bene che i mostri si possono distruggere attraverso prove di grandi coraggio.
I piccoli notano le incongruenze degli adulti, ad esempio se dico: “Non c’è da avere paura”, poi faccio scorte alimentari per un esercito, posso generare confusione e il bambino può chiedersi se fa bene a credere all’adulto in questione. Se può fidarsi.
La fiducia è indispensabile per dare sicurezza.
Ricordatevi che se non riuscite a calmare voi stessi, non potete dare sicurezza al vostro bambino !
In questi casi, fatevi supportare da altri familiari o attraverso la comunità, rete di amicizie ed eventualmente consultate gli specialisti.
Di seguito troverete dei link per condividere insieme ai bambini la storia del coronavirus.
A cura della dott.ssa Valentina Bottiglieri
https://www.youtube.com/watch?v=BGHwUs9lSLg
https://kidpass.it/wp-content/uploads/2020/03/Fiaba-Coronavirus-bambini_lo-scienziato-volante_ita.pdf
http://www.tuttoscuola.com/coronello-il-virus-birbanetello-la-favola-della-maestra-per-spiegare-il-coronavirus-ai-bambini/
https://www.mdbr.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-Galattica-al-Corona-Virus-A-curious-Guide-for-courageous-kids.pdf
- Dettagli
- Visite: 8419
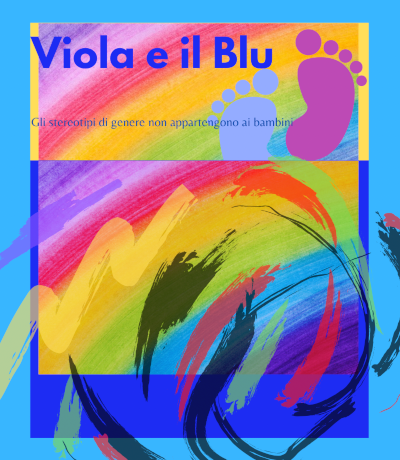
Questa storia, ispirata dalle conversazioni dell’autore con le sue figlie, indaga gli stereotipi di genere attraverso lo sguardo puro e curioso di Viola, una bambina che sa già molto bene chi è e cosa vuole diventare.
Viola gioca a calcio, sfreccia sul monopattino e ama il Blu. Scrive i colori con la lettera maiuscola, perché per lei ogni colore è unico, come le persone.
Non tutti sono d’accordo con lei. Tanti pensano che esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, specialmente gli adulti, ma Viola questo fatto non riesce proprio a capirlo. A Viola non è molto chiaro, per esempio, perché alle femmine venga sempre attribuito e debba piacere per forza il Rosa, mentre ai maschi il Blu. Così un giorno decide di chiederlo al suo papà, che fa il pittore e di colori se ne intende.

(da Viola e il blu, (2021) Matteo Bussola, Salani, Milano)
Grazie al dialogo con il suo papà scoprirà che non è sempre stato così, ma è l’uomo che, nel corso della storia, ha dimenticato il significato simbolico originale di questi colori e li ha trasformati in rigide etichette in cui catalogare le persone in base al proprio genere.
I dubbi di Viola sui colori sono solo il punto di partenza del profondo e delicato dialogo che guida questa storia, in cui vengono toccate tematiche molto più ampie e profonde. Il Rosa e il Blu, infatti, sono la punta dell’iceberg di un sistema culturale che incasella i bambini e le bambine, gli uomini e le donne, in tante piccole scatole, da cui difficilmente si riesce a uscire.
Attraverso gli occhi di Viola e del suo non convenzionale papà, Bussola cerca di spiegare il valore e l’importanza della diversità, la necessità di guardare alle cose da una prospettiva totalmente nuova, che metta al centro i gusti e le aspirazioni di ognuno, senza giudizio e nella più totale libertà. La necessità di essere delle persone storte, che guardano il mondo con gli occhi liberi dagli stereotipi che impediscono di autodeterminarsi liberamente.
In questo, Viola è una bambina fortunata. Effettivamente, tutta la sua famiglia è un po’ storta. La mamma lavora in ufficio dalla mattina alla sera, essendo un ingegnere, mentre il papà si occupa di lei e lavora da casa. Per Viola questa è la normalità, ma si renderà conto, incontrando altre persone, che per gli altri non è così. Dopo tutto, i ruoli di genere non vedono di buon occhio che sia il papà a occuparsi dei figli e la mamma a lavorare, né che alle bambine piaccia giocare a calcio e i bambini piangano. Un piccolo esempio della rigidità di questi ruoli, è offerto quando Viola e il papà vanno a prendere un gelato in città: “stai di nuovo facendo il mammo?” chiede un passante al papà di Viola. Questa domanda fa sorgere nuove perplessità in Viola, così il suo papà le spiegherà che secondo quel passante stava facendo ciò che ci si aspetterebbe faccia una mamma.

(da Viola e il blu, (2021) Matteo Bussola, Salani, Milano)
È proprio così, spiega il papà, che le persone vengono racchiuse in delle scatole, dalle quali è difficile uscire, ma anche entrare, poiché in entrambi i casi si deve per forza rinunciare a qualcosa della propria unicità. È proprio l’unicità il filo conduttore di questo delicato dialogo tra padre e figlia, la trama sottile che emerge con forza quando Viola chiede al suo papà a chi dei due genitori somiglia: “non somigli a nessuno dei due, avrai preso qualcosina da entrambi ma somigli solo a te stessa.” si sente rispondere Viola. Ciò che il papà vuole far capire a Viola è che può anche avere alcune caratteristiche fisiche, passioni, pregi o difetti simili a quelli dei propri genitori, ma lei è una persona unica con altrettante caratteristiche irripetibili e libera di esprimersi e di essere semplicemente Viola, con tutte le sue sfumature.
Imparare a riconoscere l’esistenza delle sfumature, per Bussola, significa abbandonare la convinzione di dover essere qualcuno che la società si aspetta, per diventare quello che davvero siamo, quello che davvero vogliamo essere.
Non avere paura di esprimere rabbia, dolcezza o tenerezza, senza che qualcuno decida al nostro posto che queste caratteristiche non ci appartengono. Imparare a colorare il proprio mondo di colori diversi, con sfumature diverse, imparando a vedere la bellezza nell'unicità e nella diversità di ognuno.
“Papà ma allora a cosa serve essere maschi o essere femmine?” “Serve ad avere un punto di partenza Viola, proprio come noi due davanti a questa salita che ci separa dalla nostra casetta” “La salita della morte?” “In questo caso direi piuttosto la salita della vita, diventare ciò che siamo significa arrivare in cima, o arrivare al punto della salita in cui ci sentiamo finalmente a casa. Perché essere femmine o essere maschi ha a che fare con ciò che la vita ha scelto per noi, invece diventare donne e diventare uomini ha a che fare con quello che noi ogni giorno scegliamo per le nostre vite, dipingendoci con tutti i colori che ci servono.”
di
Erica Manta
Valentina Di Nunzio
Valeria Vitillo
- Dettagli
- Visite: 15269

Nel corso di un’emergenza sanitaria e sociale senza precedenti, come quella dovuta alla pandemia da Covid-19, la comunità scientifica “psy” si è immediatamente attivata per focalizzare l’attenzione sugli effetti negativi di una situazione di tale portata sul benessere psicologico. In effetti, già dall’alba del 10 marzo, siamo stati tutti costretti a confrontarci con le nostre fragilità e le nostre parti più intime. Tra le mura casalinghe, abbiamo iniziato una convivenza forzata con tutto ciò che fino a quel momento, forse, era stato poco rilevante. Questa situazione inaspettata ha rilegato in un angolo alcune parti del nostro Io, indaffarate e impelagate nelle routine quotidiane precedenti alla pandemia, e ha permesso ad altre parti più profonde e latenti di essere svelate, mettendo a nudo le nostre fragilità. Molte di queste hanno preso la forma di sintomi, altre più profonde probabilmente hanno preso forma nei nostri sogni. Durante l’isolamento domiciliare, è emersa la necessità di trovare un equilibrio tra il chiuso e l’aperto, tra la vita interna, intima e l’apertura all’altro, prima benevolo (amici, famiglia, partner, etc), ora malevolo poiché estraneo e ignoto. In questi termini, probabilmente il sogno è stato utilizzato come possibilità di contatto con una realtà negata dalla quarantena e dalla pandemia. In aggiunta, la deprivazione degli ambienti che viviamo quotidianamente e dei relativi stimoli e simboli che li rappresentano, può aver provocato una “mancanza di ispirazione” per i sogni, forzando sempre più il nostro Io ad attingere a materiale inconscio. Portando avanti questa riflessione, è stato inevitabile chiedersi e chiedere: quali simboli e temi caratterizzano i sogni in tempo di Covid-19? E’ nata così l’idea di accogliere le descrizioni e le trascrizioni di sogni di adolescenti e giovani adulti, che in questo momento sembrano essere le vittime maggiormente silenti. Di circa 160 sogni raccolti, alcuni appartengono al periodo di lockdown, altri al periodo immediatamente successivo. Quali saranno i simboli rilevanti? Come potrebbero essere analizzati in relazione al clima vissuto nei due periodi? Il nostro viaggio nei sogni Covid si estenderà lungo diverse settimane in cui, di volta in volta, descriveremo un tema onirico risultato preponderante e particolarmente rilevante nella nostra raccolta. Pronti per un viaggio nei sogni?
di Cindy Sangiovanni
Nella sezione "News" saranno pubblicati settimanalmente articoli relaitvi al tema del Sogno al tempo del COVID 19


